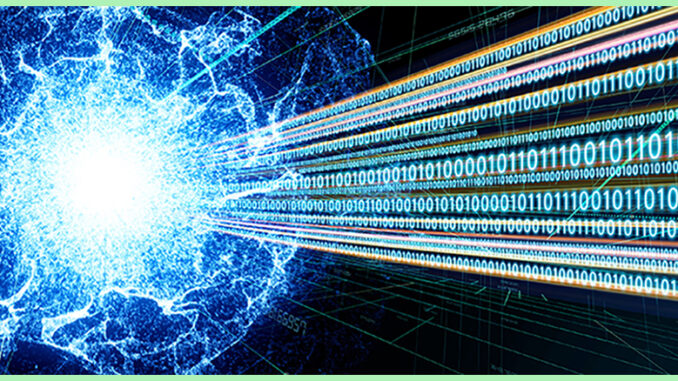
di Letizia Piredda
Una breve premessa sulla teoria dei quanti, e cioè sulla teoria delle particelle subatomiche. Lo studio della struttura della materia e delle radiazioni ha evidenziato che il movimento degli elettroni e delle altre particelle elementari viola le leggi della meccanica classica. Tra il 1924 e il 1927 i fisici elaborano una nuova teoria in grado di fornire un’adeguata rappresentazione del microcosmo atomico e subatomico: la meccanica quantistica, dove il termine quantistica si riferisce al carattere discreto, a quanti cioè a corpuscoli, messo in luce da Max Planck. Questa nuova disciplina si caratterizza per un’interpretazione probabilistica dei fenomeni esaminati. Cioè le misurazioni fisiche sono caratterizzate da un certo grado di incertezza. Tale incertezza è dovuta al principio di indeterminazione, formulato da Heisenberg:

Il principio di indeterminazione di Heisenberg
un’osservazione non può permetterci di determinare insieme con esattezza, la posizione e la quantità di moto (e quindi la velocità) di una particella in movimento come un elettrone. Se si determina la posizione, tanto più indeterminata sarà la velocità e viceversa. E questo viene spiegato così: nella fisica subatomica l’osservatore perturba inevitabilmente il sistema che sta esaminando. Bisogna accontentarsi di previsioni probabili. Un’altra conseguenza del principio di indeterminazione è il fatto che l’oggetto e il soggetto sembrano formare un tutto inscindibile e interdipendente.
E sono proprio questi gli aspetti della meccanica quantistica che interessano ai fratelli Coen: l’interferenza tra soggetto e oggetto e il carattere sfuggente della realtà, che ha come conseguenza l’impossibilità di sapere come stanno veramente le cose.
L’uomo che non c’era è un film noir. Per capire meglio il film e il collegamento con il principio di indeterminazione, faccio precedere una breve premessa sulle caratteristiche del Noir.
Inizialmente si era considerato il realismo come carattere centrale del Noir. Ma Borde e Chaumeton sottolineano come l’elemento che caratterizza il noir non sia il realismo, come avevano sostenuto Frank e Chartier, bensì l’aspetto onirico, allucinato. Questa componente onirica produce un disorientamento a tutti i livelli spaziale, temporale e etico. Inoltre la caratteristica del noir è data dalla pervasività, cioè dalla proliferazione di atmosfere oniriche.
“L’onirismo diffuso del noir porta lo spettatore a una condizione di perenne incertezza , e ad una sospensione tra percezione reale, sogno, fantasticherie”(Carluccio e Pescatore).
Si possono classificare in tre categorie gli elementi stilistici e narrativi connessi all’onirismo:
1) i riferimenti, figurativi o verbali, al sonno, al torpore, al sogno e all’incubo
2) le allusioni allo squilibrio mentale o al disorientamento psicologico dei personaggi: si ricorre ai primi piani e alla voce fuori campo per esprimere la dissociazione tra un corpo muto, quasi inanimato e un pensiero attivo, dotato di parola
3) spesso la prima apparizione di un personaggio viene fatta precedere da una scena in cui il protagonista sta dormendo, si è appena svegliato o ha espresso un desiderio o un timore del tutto irreale.
Bisogna aggiungere che i protagonisti del noir sono quasi sempre individui sfaccendati e ambigui, uomini in attesa, che indugiano, vivono alla giornata; di conseguenza sia lo spazio sia il tempo sono caratterizzati da un elemento comune : la “provvisorietà”. Non hanno una casa, un ambiente domestico, ma vivono in luoghi provvisori, come camere d’albergo, stanze in affitto, motel, bar, locali notturni.
Il protagonista de L’uomo che non c’era non possiede una personalità definita: è un individuo senza identità che non trova il proprio posto in un mondo del tutto privo di certezze.
A sottolineare questo aspetto nel film dei Coen ci sono continui riferimenti agli alieni (siamo negli Stati Uniti nell’immediato dopoguerra) che simboleggiano, con ogni probabilità, l’alienazione dello stesso protagonista, Ed Crane. Considerato il simbolo dell’Uomo moderno, privo di valori e quindi incapace di dare una direzione alla propria esistenza, lo stesso Ed dice: “Ero un fantasma, non vedevo nessuno e nessuno vedeva me”. Molte volte appare isolato nel film, con lo sguardo fisso nel nulla. Non riesce a investire emotivamente nelle cose e tanto meno nelle persone. Ci fa pensare al Mersalut di Lo straniero (1942) di Albert Camus. Nell’ultima scena della pellicola, prima dell’esecuzione, Ed riceve in sogno la visita degli alieni, proprio quando raggiunge la massima estraneità da se stesso.
Direi che il principio di indeterminazione non potrebbe trovare una corrispondenza migliore nel personaggio e nelle atmosfere provvisorie, mai definite che si susseguono nel film dei fratelli Coen.




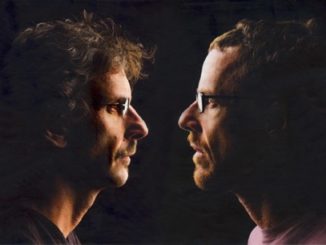
Commenta per primo